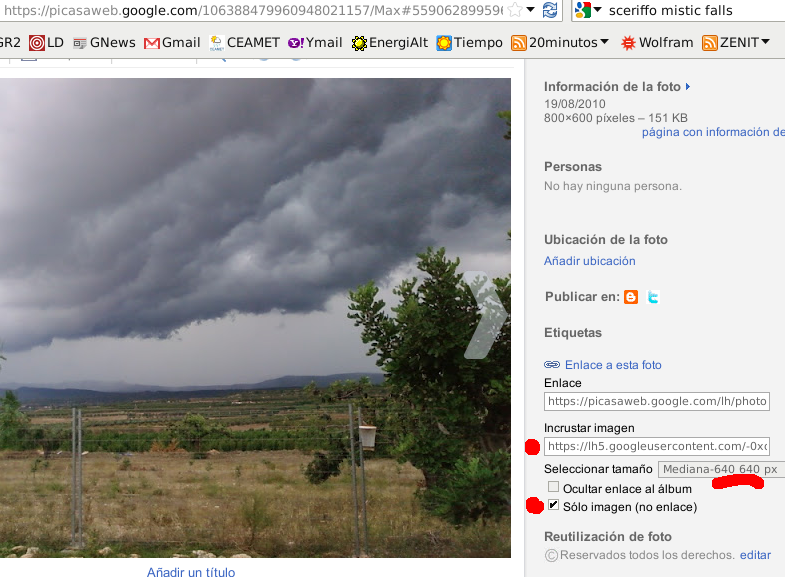Il trasformatore normalmente è composto da un nucleo di ferro al silicio laminato con due o più avvolgimenti sovrapposti o affiancati, i cui flussi magnetici risultano strettamente concatenati tramite il nucleo. Nel trasformatore si ottengono delle variazioni tra i parametri di tensione e corrente, ferma restando la potenza totale. Ossia: se in uscita si ha una tensione più alta si avrà proporzionalmente una corrente più bassa, e viceversa. Ovviamente come tutte le macchine (elettriche o meno) si hanno delle perdite, che però in un trasformatore ben costruito possono essere percentualmente molto basse, tanto da poter arrivare, per i grandi e grandissimi trasformatori, a rendimenti del 98% e oltre. Più il trasformatore è piccolo e maggiori sono le perdite, causa maggiore dispersione di flusso magnetico per le piccole dimensioni del nucleo e maggiore resistenza nei fili di rame, molto sottili.
L'attuale tendenza di costruzione privilegia l'uso di nuclei più grandi rispetto al peso del rame, a causa del maggior costo del rame negli ultimi anni, così si trovano in commercio trasformatori con nucleo molto spesso, in genere più spesso della larghezza del nucleo centrale, in netta controtendenza sul passato, quando invece i nuclei erano più sottili e gli avvolgimenti molto più cospicui.
Fortunatamente per i piccoli trasformatori (sotto i 5 kVA) molti fattori sono stabiliti a priori, frutto ormai di molta pratica e lunga sperimentazione. I lamierini che ne compongono il nucleo, per i tipi normalmente in commercio, sono di spessore 0,5 o 0,35 mm. Raramente e per usi particolari possono trovarsi con spessori più sottili. Sono di forma "E-I" per trasformatori a mantello con dimensioni stabilite e unificate a norme UNEL oppure DILDA.
Questo allegato è un piccolo manuale sui trasformatori:
Le spiegazioni dettagliate, con tabelle e semplici formule di calcolo, le rimando alla sua lettura.
L'avvolgimento connesso alla rete di alimentazione, qualsiasi sia la sua tensione, di solito viene chiamato "Primario", gli altri da cui si prelevano le tensioni "trasformate" vengono chiamati "Secondari". Il tipo di trasformatore più semplice è quello con due soli avvolgimenti, uno primario e uno secondario.
Il primario del trasformatore di solito è avvolto più vicino al nucleo, semplicemente per comodità, in quanto se tutto l'avvolgimento è ben fatto e serrato, e riempie completamente le "finestre", ossia lo spazio per avvolgerlo, tutti gli avvolgimenti sono intercambiabili, purché se ne rispettino le tensioni di lavoro. Mi spiego: se si ha un trasformatore con un avvolgimento calcolato per 220V e uno per 12V alimentando il secondo con tensione di 12V alternati se ne avranno 220 sull'altro, e viceversa.
Il trasformatore, se ben fatto, a vuoto assorbe pochissimo, in genere tra 5% e lo 0,5% della corrente assorbita sotto carico. Questo anche per piccoli trasformatori.
L'assorbimento a vuoto è dato dalle caratteristiche costruttive, ossia dimensioni del nucleo e soprattutto dal numero di spire avvolte. Con un numero di spire maggiore si ha minore assorbimento a vuoto, a causa della maggiore induttanza della bobina, minore flusso minimo di magnetizzazione e minore perdita percentuale di potenza per induzione del nucleo di ferro, però si ha maggiore perdita per resistenza Ohmica nel filo di rame con cui è avvolto, che si traduce poi in calore durante il funzionamento sotto carico. La buona realizzazione è il il miglior compromesso tra le due cose. Pratica e sperimentazione passate hanno già semplificato molto.
Nel caso che un trasformatore funzioni a vuoto, ossia con secondario aperto, nel primario si produce una tensione di autoinduzione che, come abbiamo detto, ne limita la corrente ad una piccola percentuale di quella massima di funzionamento. A causa della stretta concatenazione tra gli avvolgimenti, viene indotta sul secondario (nel caso più semplice di secondario singolo) una tensione alternata sinusoidale perfettamente proporzionale al numero di spire avvolte, ma di verso contrario al senso della tensione primaria.
Nel caso in cui il secondario venga chiuso su di un carico, circola una corrente proporzionale all'impedenza del carico, ma di verso opposto alla corrente che scorre nel primario. Si produce così un flusso magnetico in opposizione di fase a quello generato dal primario, che induce nello stesso una ulteriore Forza Contro ElettroMotrice che va a sommarsi a quella di autoinduzione. Per potersi mantenere la corrente di magnetizzazione viene assorbita dalla rete una corrente superiore, fino a ristabilire nel nucleo l'intensità del flusso magnetico originale. Il tutto, com'è intuibile, avviene istantaneamente col variare del carico.
Da questo si capisce che: A vuoto o in ogni altra condizione di carico il flusso magnetico che attraversa il nucleo si mantiene costante, ed è stabilito a priori al momento della costruzione.
Se il trasformatore si brucia per sovraccarico, dipende esclusivamente dalla produzione di calore dovuta alla resistenza ohmica degli avvolgimenti.
Da questo punto di vista emerge che: Il trasformatore è una macchina perfettamente autoregolante, che assorbe in ingresso tanta potenza quanta ne eroga in uscita, maggiorata soltanto dalla potenza assorbita a vuoto e delle perdite percentuali.
La potenza assorbita a vuoto e le perdite percentuali si possono limitare e vengono stabilite in sede di costruzione, e se l'avvolgimento avesse "resistenza zero", anche da un piccolo trasformatore si potrebbero prelevare potenze enormi. Le perdite nel nucleo avvengono per correnti parassite indotte nel ferro, ragion per cui viene laminato e le lamine sono verniciate o ossidate sulle due facce, così da limitare al massimo conduzioni indesiderate. Le correnti per induzione nel nucleo aumentano col quadrato dell'induzione magnetica, che a sua volta aumenta al diminuire del numero di spire. Non si possono mettere troppo poche spire, altrimenti si surriscalda il nucleo e aumenta spropositatamente la corrente a vuoto, non se ne possono mettere troppe per via della resistenza del filo con le sue perdite.
Il trasformatore si riscalda tanto più quanto è alta la corrente che scorre negli avvolgimenti. Come Joule insegna: le perdite in calore aumentano col quadrato della corrente circolante. Il rame è un ottimo conduttore, inferiore solo all'argento (che costa troppo.....), dimensionandone la sezione opportunamente se ne limita la resistenza, ma purtroppo non si può annullare. La resistenza e le perdite aumentano anche col calore, aumentando la temperatura aumenta la resistenza specifica dei metalli, e anche del rame. Facendo in modo che il trasformatore sia ben ventilato e possa dissipare la temperatura prodotta, se ne limitano le perdite. E' una macchina molto precisa, e ha di buono che si può sovraccaricare anche del triplo o del quadruplo della sua potenza massima nominale per brevi periodi, senza che ne soffra più di tanto, purché non raggiunga temperature pericolose per gli isolanti impiegati. Questo è valido anche per i motori ad induzione (trifasi e monofasi....) e per gli alternatori, sincroni o meno.
Da quanto sopra si capisce il perché nei piccoli UPS, nonostante il trasformatore sia costruito con nucleo di dimensioni contenute, vengano dati per potenze anche quattro o cinque volte superiori alle sue dimensioni effettive. Si tratta di potenza temporanea, limitata nel tempo dalla ridottissima capacità della batteria di tampone.
Per adesso mi fermo quì, spero che l'argomento sia di interesse generale, o almeno per qualcuno. Altrimenti rimane come "promemoria online".
La discussione ovviamente rimane sul piano pratico, trattazioni teoriche complesse sono assolutamente fuori luogo.